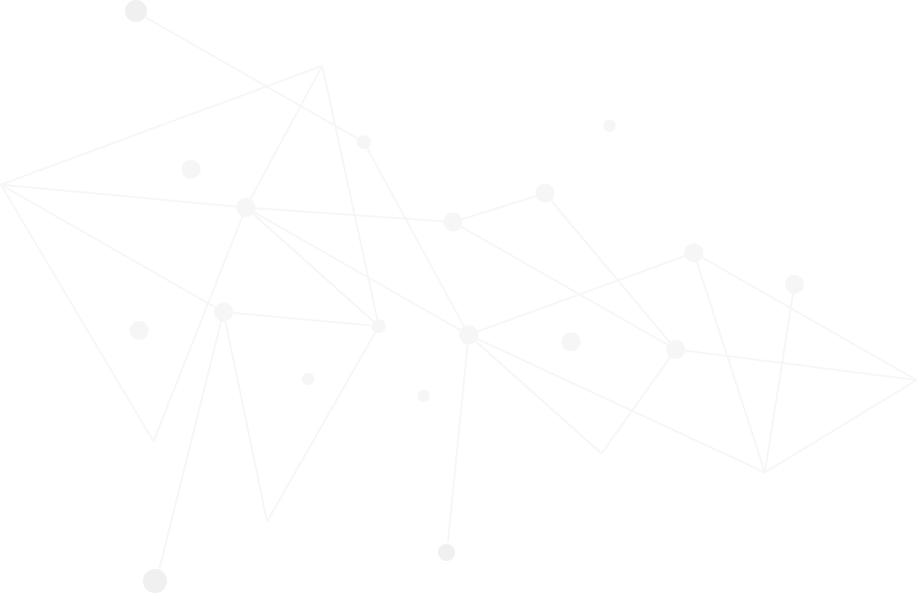Cosa sta accadendo nel mondo dei social media? La recente decisione di Facebook e Twitter di bannare il presidente degli Stati Uniti uscente, Donald Trump, come fosse un utente qualsiasi, è una scelta che sembra andare ben oltre gli “standard della community” e crea un precedente preoccupante. Ne abbiamo parlato con Alberto Mingardi, direttore dell’Istituto Bruno Leoni, professore associato di Storia delle Dottrine Politiche all’Università IULM di Milano e autore di “Contro la tribù – Hayek la giustizia sociale e i sentieri di montagna”.
I nuovi media sostituiranno i social tradizionali?
Può un social network censurare le idee? Il caso Trump apre interrogativi sul potere della tecnocrazia ed accendo il dibattito. Quale saranno gli effetti futuri? Assisteremo ad una fuga degli utenti verso i media emergenti?
«La censura di Trump crea un doppio cortocircuito. Equipara di fatto i social network agli editori tradizionali, scegliendo di non dare voce a un utente, esattamente come farebbe l’editore di un quotidiano – sottolinea Alberto Mingardi – L’interrogativo attuale, a fronte delle problematiche in cui sono coinvolti, tra cui i diritti di copyright, a difendersi sostenendo di non essere editori, d’ora in avanti? Dall’altra, mette in crisi coloro che hanno sempre denunciato i social perché sottratti alla regolamentazione pubblica: Twitter e Facebook si sono, letteralmente, autoregolati. L’espulsione di Trump è un atto eclatante ed apre un dibattito che si svilupperà a lungo».


LEGGI ANCHE: Se censurare è democrazia, ovvero la fine del mito di Internet come strumento di libertà
Le Big Tech, nate come espressione del libero mercato, sembrano ormai legate indissolubilmente ai decisori politici, tanto da fornire output non desiderabili, tali da far fallire le proprie stesse premesse. Il risultato è un conglomerato di potere, più vicino alle logiche del crony capitalism che del free market.
Parler in crescita
Alla censura in atto su Twitter e Facebook si è unita l’offensiva contro Parler da parte di Google e Apple (con la rimozione dell’App dai rispettivi store online) e di Amazon dai propri server. La fuga degli investitori, testimoniata dai crolli in borsa delle piattaforme, si tradurrà anche in una fuga degli utenti verso piattaforme alternative? In una logica di libero mercato l’ipotesi diventa realistica, nel momento in cui altri player saranno in grado di offrire servizi altrettanto interessanti. Anche se lo scoglio resterà sempre il solito: la massa critica di persone che andranno ad animare una nuova piattaforma e quanto il valore aggiunto di quest’ultima verrà percepito dagli utenti, sempre più polarizzati in “tribù” distinte e impermeabili tra loro.
«Twitter e Facebook ci ricordano tutti i giorni come sia cambiato Internet – continua Mingardi – Speravamo fosse uno spazio aperto, nel quale potesse svilupparsi un dibattito più razionale e sereno, invece i social replicano, in certi casi inasprendola, la tribalizzazione anche politica che si riscontra nelle nostre società. Il cerchio delle cose che leggiamo si restringe. Gli algoritmi dei social media aiutano ciascuno di noi a costruire la propria echo-chamber, impermeabile a qualsiasi contaminazione di altre opinioni».

 Alberto Mingardi
Alberto Mingardi
Professor Mingardi, l’assenza di dibattito radicalizza ogni utente sulle proprie posizioni? La comfort zone dei propri amici diventa quella del proprio algoritmo di gradimento.
«La frequentazione assidua di queste piattaforme rinforza le convinzioni di ogni utente, un po’ come un tempo si faceva comprando in edicola l’Unità e il Giornale. Solo che qualsiasi quotidiano, anche il più schierato, è plurale negli argomenti trattati: nei media tradizionali c’era sempre l’articolo di cricket in un magazine stampato per gli appassionati di calcio.
Nel nuovo mondo polarizzato, alcune tribù hanno avuto più successo di altre, come nel caso di quella dei sostenitori di Donald Trump nel 2016. Quattro anni fa nessuno o quasi si sarebbe aspettata l’elezione del candidato repubblicano, che aveva costruito un grande seguito su Twitter (memorabile la sua battuta al raggiungimento del milione di follower: “È come avere il New York Times, senza pagare per il suo bilancio in dissesto”). La sua lezione non è stata sprecata e nel frattempo anche i democratici si sono messi al lavoro per recuperare terreno. La comunicazione politica è diventata così sempre più aggressiva, intollerante, tribale».


Riconoscere una fake news
Le fake news bastano a censurare il post di un account privato. Chi decide e come si riconosce una notizia fake?
«Quando ti metti a definire una fake news non ne esci più. Cos’è realmente? Alcune sono evidenti, altre meno. Dove comincia la “balla” e dove inizia l’opinione? È un lavoro che possono fare i fact checkers, ma anche costoro debbono crearsi una reputazione “sul mercato”: guai se diventano censori ufficiali.
Le misure di contrasto alle fake news riprendono anche un po’ il target dei social, riflettono gli utenti: FB, che è più popolare e trasversale ha lasciato più libertà di circolazione delle idee rispetto a Twitter, che ha filtri più coerenti con la sua base utenza».
Serve una normativa? Molti decisori politici invocano un provvedimento che ponga limiti allo strapotere delle piattaforme social.
«Regolare decisioni arbitrarie di soggetti privati, come le Big Tech, con le decisioni, altrettanto arbitrarie, della politica e della legge? Forse non è la soluzione migliore. Bisognerebbe scommettere sulla diversificazione e sul mercato: se le persone non si troveranno bene in una piattaforma, migreranno in un’altra piattaforma, quando qualcuno proporrà loro offerte alternative e altrettanto credibili. Si pensi alla crescita di Linkedin, che è una specie di porto sicuro dalle polemiche più urlate. Vedremo come evolverà Parler, ora che Twitter ha cacciato Trump».


I social media diventano editori proprio nel momento in cui la fiducia nei media tradizionali è al minimo storico.
«L’assenza di fiducia nei media tradizionali non per forza è un fatto positivo: le grandi testate hanno anche una funzione di scrematura dei punti di vista, l’opinione di mio cugino vale meno di quella del fondo del Wall Street Journal. Si presume che chi scrive per queste testate abbia una capacità di analisi maggiore. I grandi media hanno la funzione di dirti che ci sono cose che meritano la prima pagina e altre che stanno bene a pagina 25, una funzione preziosa, ben diversa dalla home di un social, che invece è basata su una scala di importanza personalizzata per i gusti di ciascuno di noi.
La crisi dell’editoria, e dei media tradizionali in generale, ha portato questi editori a motivare la propria tifoseria, tribalizzando a loro volta l’informazione: solo un altro modo per tamponare l’emorragia di lettori e ascoltatori, una strategia che tuttavia non sembra funzionare molto. Quello delle tifoserie è un gioco che, ad esempio, è stato chiaro per tutto il 2020 con l’isterismo pandemico, alimentato dai media tradizionali in una rincorsa perversa agli umori dei social».


Attrarre l’audience
Il problema dell’autorevolezza, non riguarda solo i media ma anche la comunicazione politica. La pazienza delle persone è poca, l’intrattenimento è tutto: tempo una frazione di secondo si deve decidere se scrollare la home o soffermarsi su un tema.
«La comunicazione politica dovrebbe portare a conoscere qualcuno che mi somiglia ma che, per preparazione su certi temi e capacità, è meglio di me. Questo era il vecchio approccio: attualmente, nella sfiducia generalizzata, la gente si accontenta di intrattenimento: se lo show è divertente mi accontento, anche se i protagonisti non sono migliori di me e forse sono perfino peggio.
Il problema è che finché concedo il 5% del Pil all’intrattenimento (cinema, teatro, Netflix…) la situazione rientra nella normalità, ma se noi scegliamo i politici come in base alle loro doti di entertainment, stiamo scegliendo persone, sulla base di questo criterio, per affidargli metà del PIL; questa eventualità, che si sta concretizzando nelle nostre società attuali, diventa un problema.

 Alberto Mingardi, Contro la tribù: Hayek, la giustizia sociale e i sentieri di montagna, Alberto Mingardi, Marsilio, 2020
Alberto Mingardi, Contro la tribù: Hayek, la giustizia sociale e i sentieri di montagna, Alberto Mingardi, Marsilio, 2020
La narrazione mainstream è ormai un “framing” preciso che esclude ogni altra “versione dei fatti”, censurandola dalla storia ed escludendo ogni revisionismo?
C’è sempre una realtà, tra le tante possibili, che diventa mainstream a discapito di altre. Eppure non sempre la versione che sopravvive è anche la più aderente ai fatti. Prendi l’esempio del Titanic: uno sceneggiatore del film di James Cameron trovò che un banchiere, a bordo, era rimasto sulla nave che colava a picco citando il posto al suo maggiordomo. Ne discussero con il regista e gli altri autori ma scelsero di non inserirlo nel film. Perché? Forse perché erano convinti che le persone non si sarebbero appassionati alla vicenda, forse perché gli sembrava troppo strano che un riccone potesse essere anche una persona animato da tanto spirito di sacrificio. In un caso o nell’altro, vediamo un approccio ideologico magari non “scelto” apertamente ma senz’altro pervasivo e penetrato a fondo nelle nostre società».
A proposito di Hollywood: in prima fila, nelle proteste contro Trump, artisti, intellettuali, influencers e celebrità. Sembra cambiato poco da fine anni ’60, quando contro Nixon iniziò una vera e propria rivolta, capeggiata dalle star.
«Gli artisti, gli intellettuali da sempre sono stati “contro” il potere costituito, offrendo spesso una visione alternativa, ma la cose dai tempi di Nixon sono cambiate moltissimo: le proteste di ieri hanno gettato le fondamenta culturale dell’establishment di oggi. Molto spesso la ribellione è di maniera e in realtà perfettamente coerente con presupposti ideologici comunemente accettati, soprattutto nel mondo della comunicazione e dello showbiz. C’è un conformismo dell’anticonformismo».


Abbiamo citato Parler che, come altre piattaforme, si sta affacciando nel mercato dei social media. Se la soluzione non può arrivare dallo Stato, dovrà arrivare giocoforza dal mercato: nuove applicazioni, oppure…
«La mia proposta è far pagare la gente per scrivere. Un piccolo pedaggio. Sembra una proposta scandalosa e irricevibile ma se ci pensi non lo è: un tempo il costo per comunicare le proprie idee, o mandare a quel Paese qualcuno era alto. Se avevi un reclamo da fare a un’azienda, ad esempio, dovevi prendere carte e penna e perdere tempo e soldi per la spedizione della lettera. Oggi il costo di una comunicazione di questo tipo è irrisorio, il tempo di due minuti per scrivere un tweet; l’utente consumatore si ritiene invincibile e spesso comunica alle aziende con una certa aggressività, pretendendo risposte esaustive e in tempo reale. Per non dire dei commenti agli articoli di giornale: una sfilza di vaffa, neanche troppo infiorettati. Ma questa veemenza perché non viene utilizzata nei confronti degli operatori pubblici? Perché sui social media e online si trasferiscono le nostre aspettative della realtà: dalle aziende private e dai brand ci aspettiamo efficienza, mentre nei confronti dello Stato non abbiamo aspettative, perché siamo già abituati alla sua inefficienza. Insomma, e se tornassimo a fare pagare alla gente il francobollo?».
Source: http://www.ninjamarketing.it/